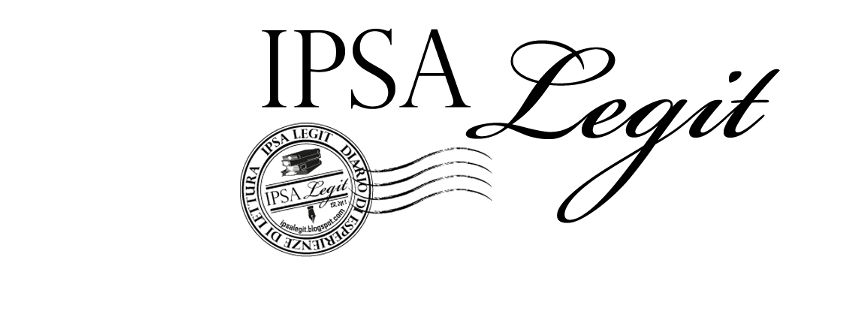In queste settimane, con la mia classe terza, sto lavorando (a distanza, naturalmente) su William Shakespeare. I miei piani iniziali sono stati leggermente sovvertiti dalle circostanze, però sto tentando ugualmente di far sentire ai miei studenti la magnificenza della scrittura e l’umanità sconfinata di questa suprema voce della letteratura, che è anche la nostra voce. Per cercare di adottare un linguaggio quanto più divulgativo e visivo possibile sto consultando, a tratti, il manuale “pop” a cura di Stanley Wells (et al.), The Shakespeare Book, che fa parte della collana Penguin Random House “Big Ideas Simply Explained”.
La prima tappa del mio percorso con i ragazzi – passaggio obbligato per avvicinarsi alla sensibilità adolescenziale – è stata Romeo and Juliet, che molti avevano già scelto come lettura delle vacanze di Natale: alla scena del balcone dal film di Franco Zeffirelli ho aggiunto la lettura in inglese della stessa scena e del Prologo. È ora tempo, però, di passare allo studio di un tema shakespeariano universale, che è quello del potere; in questi giorni, quindi, mi sono letta il breve ma puntuale saggio di Stephen Greenblatt (tra i più grandi studiosi del Bardo) Il tiranno. Shakespeare e l’arte di rovesciare i dittatori (Rizzoli, trad. it. di R. Zuppet).
Il saggio si apre con una serie di domande alle quali l’autore intende cercare una risposta rileggendo i drammi shakespeariani: “Com’è possibile che un intero Paese cada nelle mani di un tiranno? Perché un gran numero di persone accetta consapevolmente di essere ingannato?” Sono domande spaventosamente vicine al nostro tempo, come tutte le esplorazioni dell’umano che troviamo inoltrandoci nelle selve, spesso oscure, del dettato di Shakespeare. “I suoi drammi”, suggerisce Greenblatt, “sondano i meccanismi psicologici che conducono una nazione a dimenticare i propri ideali e persino il proprio interesse personale. Perché qualcuno, si chiede Shakespeare, dovrebbe appoggiare un leader paurosamente inadatto a governare, una persona pericolosa e impulsiva, malvagia e subdola, o indifferente alla verità?”
Sono tanti i tiranni citati nel saggio, ma prima di nominarli mi soffermo momentaneamente sulla trattazione del Riccardo II, un dramma forse meno noto di altri, ma nel quale Shakespeare mette in atto una rivoluzione inaudita nel sistema dei valori elisabettiano. È una storia che racconta la caduta di un re – creatura prossima al divino, al vertice della gerarchia macrocosmica della cultura del tempo. Al lettore moderno i lunghi monologhi di Riccardo sembrano soprattutto atti di dolorosa introspezione, ma per lo spettatore del Cinquecento e Seicento suonavano come dichiarazioni clamorose, che incrinavano l’intera visione del mondo allora conosciuta. In questo dramma un re – il garante dell’ordine del cosmo – si lascia attrarre dal nulla, dall’avvilimento e dall’annullamento di sé stesso, intraprendendo il “dolce cammino” della disperazione. Alla vigilia della deposizione si chiede: “Che cosa deve fare il re ora? Sottomettersi? / Il re lo farà. Venire deposto? / Il re lo accetterà. Deve perdere / Il nome di re? […] Darò […] / il mio vasto regno per una piccola tomba, / una piccola, piccola tomba, una tomba oscura; / oppure verrò sepolto sulla strada maestra” e più tardi “ho reso vile la gloria / e la sovranità una schiava; / dell’orgogliosa maestà un suddito […] / Non ho nome né titolo / […] / ora non so con che nome chiamarmi” (trad. it. di A.L. Zazo, edizione Mondadori).
Nel Riccardo II il tiranno sembra essere Henry Bolingbroke, che si appropria del suo trono; meno ambigua è la figura del dittatore per eccellenza, Riccardo III, di cui Greenblatt scrive in un eccellente capitolo sul rapporto del tiranno con coloro che lo circondano, e che si relazionano con lui secondo i vari gradi dell’asservimento inerte, della complicità malvagia, del terrore muto, della flebile resistenza. È un capitolo di grande attualità, che con lucidità avvicina evidentemente Shakespeare alle tragedie storiche del Novecento e di oggi.
 Nel corso del saggio si nominano re Lear, il sovrano impazzito che sovverte il principio per cui il monarca è deputato al controllo dell’universo, e il tiranno Macbeth, che commette l’atto empio per eccellenza dell’uccisione del re. Profondissimo suona il celebre monologo dello scozzese assassino, che una volta sul trono non può che fare i conti con i peccati che ha compiuto: “Domani, e domani e domani / striscia così, col suo misero passo, di giorno / in giorno, fino alla zeta del nostro tempo scritto; / e tutti i nostri ieri han rischiarato / ad altri pazzi / la strada della polverosa morte. / Spegniti, spegniti breve candela! / La vita non è che un’ombra vagante, un povero attore / che avanza tronfio e smania la sua ora / sul palco, e poi non se ne sa più nulla” (trad. it. di N. D’Agostino, edizione Garzanti).
Nel corso del saggio si nominano re Lear, il sovrano impazzito che sovverte il principio per cui il monarca è deputato al controllo dell’universo, e il tiranno Macbeth, che commette l’atto empio per eccellenza dell’uccisione del re. Profondissimo suona il celebre monologo dello scozzese assassino, che una volta sul trono non può che fare i conti con i peccati che ha compiuto: “Domani, e domani e domani / striscia così, col suo misero passo, di giorno / in giorno, fino alla zeta del nostro tempo scritto; / e tutti i nostri ieri han rischiarato / ad altri pazzi / la strada della polverosa morte. / Spegniti, spegniti breve candela! / La vita non è che un’ombra vagante, un povero attore / che avanza tronfio e smania la sua ora / sul palco, e poi non se ne sa più nulla” (trad. it. di N. D’Agostino, edizione Garzanti).
Ma il dramma politico che mi ha sempre appassionato di più è Julius Caesar. Il raggio che Shakespeare conferisce all’interiorità di Bruto è amplissimo, e come nel resto della sua scrittura il drammaturgo non ci offre la comodità di un’opinione univoca, di un giudizio valido a priori. Bruto è un assassino o un salvatore della patria? È un “uomo d’onore”, come lo definisce Antonio nell’indimenticabile monologo sul cadavere di Cesare, o un volgare parricida? Nella sua decisione di stroncare il germe della tirannia, Bruto è un magnifico eroe moderno, condannato alla tragedia perché sceglie di non diventare tiranno lui stesso uccidendo anche Antonio. E la sopravvivenza di Antonio è il movente della sua fine e di conseguenza, con l’avvento di Ottaviano, la fine stessa della Repubblica. Neanche l’assassinio del tiranno è la soluzione al problema.
Come scrive Greenblatt in conclusione di questo saggio: “Ci sono periodi, talvolta anche prolungati, in cui le motivazioni più crudeli degli individui più ignobili sembrano trionfare. Shakespeare, tuttavia, credeva che i tiranni e i loro tirapiedi prima o poi avrebbero fallito. […] La migliore possibilità di recuperare l’onestà collettiva era, riteneva, l’azione politica dei comuni cittadini. Il drammaturgo non perse mai di vista le persone che si chiudevano in un silenzio tenace quando venivano esortate a urlare il loro sostegno per il tiranno”. Una riflessione sempre valida, che il cittadino, nel suo ruolo laicamente sacro di difensore della polis, non dovrebbe mai dimenticare.