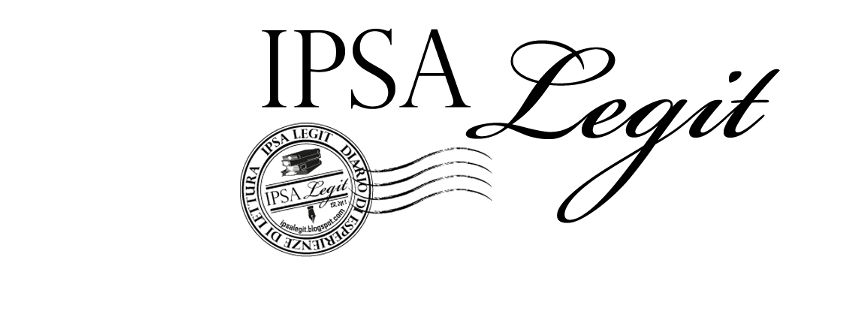|
| Un souvenir del Bröhan-Museum, il museo dell'art nouveau a Berlino |
Negli ultimi dieci giorni, dopo Il grande Gatsby di Fitzgerald – ritratto della disperazione della gioventù americana postbellica, incapace di vivere il presente – ho letto il doloroso romanzo di Simon Mawer La casa di vetro (tradotto in italiano da Massimo Ortelio per Neri Pozza). L’ambientazione cronologica iniziale è la stessa del libro di Fitzgerald, gli anni Venti – con la loro opulenza e la scintillante proiezione verso il futuro – ma con il procedere dei capitoli il romanzo affronta i mostri del Novecento, il precipitare dell’Europa nella nuova guerra, la dissoluzione della Cecoslovacchia, l’invasione dei nazisti e poi l’arrivo dell’Armata Rossa, fino a toccare il 1990, con la sua intuizione della caduta della cortina di ferro.
Il principio che tiene insieme il racconto – la costruzione e le sorti di una “casa di vetro” – è di per sé un ossimoro: può infatti una casa, luogo deputato al rifugio e alla dedizione all’individualità, essere una vetrina offerta allo sguardo pubblico? Il giorno dell’inaugurazione, il padrone di casa, Viktor Landauer, dichiara orgoglioso che la volontà di vivere in un soggiorno che è una scatola di vetro dimostra la trasparenza e l’onesta dei suoi abitanti; ma lo sviluppo della storia dirà di inganni, di tradimenti, di fughe, di feroci compromessi con la Storia.
La prima parte del romanzo, quella dedicata al progetto e alla costruzione della casa, è straordinaria; è quasi una ekphrasis architettonica, che celebra le qualità della materia con l’ambizione della rappresentazione della luce e dello spazio come concetto filosofico. Rainer von Abt, l’autore del disegno, dichiara: «“L’acciaio avrà la trasparenza dell’acqua. La luce sarà solida come le pareti e le pareti limpide come l’aria. Creerò una casa diversa da qualunque altra, spazi capaci di mutare funzione […] una casa che si fonde con il giardino, un luogo naturale e artificiale nello stesso tempo”». Al loro primo ingresso, «Liesel e Viktor rimasero a bocca aperta davanti a quel trionfo di lucentezza: la luce rimbalzava dai pilastri cromati, splendeva sulle pareti, scintillava sulla rugiada del giardino, riverberava dai vetri […] rendeva il pavimento di linoleum color avorio quasi traslucido, come se fosse ricoperto da un velo d’acqua». Luce, aria, acqua: la casa dei Landauer è un Raum (spazio), intessuto di una insostenibilità solo apparente, perché l’edificio è sorretto da pilastri d’acciaio e da una parete d’onice che convoglia la luminosità dell’esterno fino a creare una sorta di incantesimo, una visione di fuoco.
La “villa Landauer” del romanzo è ispirata a una casa veramente costruita alla fine degli anni Venti nei pressi di Brno, in Repubblica Ceca. Villa Tugendhat, patrimonio dell’umanità dal 2003, è il simbolo di un’epoca vestale del progresso, ma soprattutto di una speranza impossibile: quella della condivisione definitiva e della convivenza pacifica dell’uomo con gli altri uomini, dentro la natura.
 |
| Villa Tugendhat. Esterno ed interno del soggiorno, con le vetrate e la parete in onice. (Immagini tratte da Wikipedia e da czechtourism.com) |