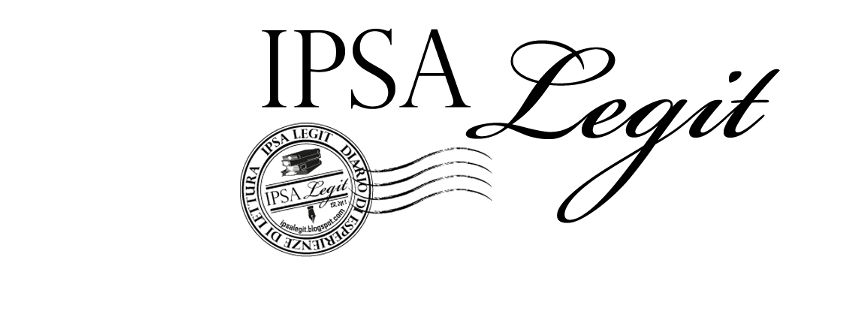Il passaggio dall’estate all’autunno, con l’inizio della scuola e tutte le ulteriori difficoltà (sempre più serie) connesse a quest’evento, mi ha travolta, e pur continuando a leggere molto, anche se con meno regolarità, sono riuscita a scrivere poco. In quest’ultimo mese e mezzo, però, posso dire di aver scoperto almeno tre libri importanti.
25 ottobre 2020
Dall'estate all'autunno
7 settembre 2020
The Bookshop, di Penelope Fitzgerald
Nei giorni scorsi mi sono imbattuta in un film che mi è piaciuto molto, La casa dei libri (in originale La librerìa) diretto dalla regista spagnola Isabel Coixet. Guardandolo ho riconosciuto i tratti di un libro comprato un paio d’anni fa e però rimasto sullo scaffale, come spesso accade quando gli impegni della vita quotidiana impediscono di mettere ordine fra le cose più importanti – cioè, le letture. Cercando qualche rapida informazione online ho avuto conferma che in effetti il film è tratto da The Bookshop di Penelope Fitzgerald (1978; pubblicato in italiano da Sellerio nel 1999), così, approfittando della coincidenza, ho deciso finalmente di leggerlo.
 Come scrive la sua biografa Hermione Lee nella Prefazione alla mia edizione del romanzo: “La visione del mondo [di Penelope Fitzgerald] era divisa tra ‘sterminatori’ e ‘sterminati’. Era solita dire: ‘Mi sento attratta dalle persone che sembrano essere nate sconfitte o profondamente perdute’. Era un’autrice ironica, con un tragico senso della vita”. Eppure, e nonostante tutto ciò che accade e che porta alla conclusione della storia, The Bookshop sembra offrire uno spiraglio di redenzione e di gioia, che è offerto proprio dai libri e che l’autrice rappresenta nel suggestivo episodio in cui Florence dispone in negozio la propria merce: “Anche se le era stato insegnato che non si guardano mai i libri mentre si sta lavorando, ne aprì un paio – vecchie edizioni Everyman, con le copertine sbiadite color oliva e i caratteri dorati”. Ed è Florence stessa a dichiarare, in una lettera al suo reticente avvocato, quale sia il significato della letteratura nella nostra vita: scrive che un buon libro è linfa vitale, di cui fare tesoro per spingere la vita oltre sé stessa, e che per questo si deve considerare “un prodotto di prima necessità”. Una definizione da non dimenticare, in questi nostri tempi difficili in cui il bisogno di bellezza e di istruzione è così dolorosamente sottovalutato.
Come scrive la sua biografa Hermione Lee nella Prefazione alla mia edizione del romanzo: “La visione del mondo [di Penelope Fitzgerald] era divisa tra ‘sterminatori’ e ‘sterminati’. Era solita dire: ‘Mi sento attratta dalle persone che sembrano essere nate sconfitte o profondamente perdute’. Era un’autrice ironica, con un tragico senso della vita”. Eppure, e nonostante tutto ciò che accade e che porta alla conclusione della storia, The Bookshop sembra offrire uno spiraglio di redenzione e di gioia, che è offerto proprio dai libri e che l’autrice rappresenta nel suggestivo episodio in cui Florence dispone in negozio la propria merce: “Anche se le era stato insegnato che non si guardano mai i libri mentre si sta lavorando, ne aprì un paio – vecchie edizioni Everyman, con le copertine sbiadite color oliva e i caratteri dorati”. Ed è Florence stessa a dichiarare, in una lettera al suo reticente avvocato, quale sia il significato della letteratura nella nostra vita: scrive che un buon libro è linfa vitale, di cui fare tesoro per spingere la vita oltre sé stessa, e che per questo si deve considerare “un prodotto di prima necessità”. Una definizione da non dimenticare, in questi nostri tempi difficili in cui il bisogno di bellezza e di istruzione è così dolorosamente sottovalutato.17 agosto 2020
The Secrets We Kept, di Lara Prescott
 |
| Olga Ivinskaya e Boris Pasternak (immagine: pasternak-trust.org) |
15 agosto 2020
Webinar: "A casa con Jane Austen"
Cari lettori di Ipsa Legit, la scorsa primavera, durante l'isolamento, ho preparato per la Jane Austen Society of Italy un webinar (seminario in rete) in sei puntate intitolato In casa con Jane Austen.
In ognuno dei sei capitoli del seminario ho tentato di esplorare il significato della casa nella biografia e, soprattutto, nelle opere della scrittrice, prendendo spunto dal mio libro Le case di Jane Austen (pubblicato da flower-ed nel 2017).
Oggi, approfittando dell'estate e della festività, metto anche a vostra disposizione il link alle sei puntate del webinar, sperando che possano essere un gradevole passatempo per trascorrere quest'ultima parte di agosto (che siate al lavoro, in vacanza, oppure a casa).
Potete accedere alla playlist delle sei puntate cliccando qui:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb1WomCWAlKxfGAC_MZI8DklXzb9MRgxB
Buona visione!
8 agosto 2020
The Jane Austen Society, di Natalie Jenner
Letture di un viaggio in Sicilia
 |
| Lo scrittoio di Salvatore Quasimodo a Modica |
 |
| Aci Trezza, il porto (in alto: la casa del nespolo) |
20 giugno 2020
I Goldbaum
 Un altro aspetto importante di questo romanzo è la presenza femminile, che si moltiplica in personaggi secondari ma non minori, come Lady Goldbaum o la giardiniera Withers, ma sicuramente si raddensa nella figura di Greta, l’austrica nata Goldbaum e sposata a un Goldbaum inglese, che incarna la transnazionalità del cognome che porta. Greta è stata una bambina vivace e una ragazzina ribelle e anche da moglie quasi aristocratica non permette al mondo di darla per scontata: di lei questa storia ci racconta la bellezza, le trasgressioni, le sofferenze, ma è nella sua relazione con lo spazio che la circonda che ci vengono offerte le sue immagini più vivide e indimenticabili. In particolare, nei primi anni del suo critico matrimonio d’interesse, Greta è insofferente alla vita chiusa e regolata dalle decine di orologi della casa di suo marito e decide quindi di spostare se stessa, la propria anima e tutta la propria potenzialità d’azione (di donna e di personaggio) fuori, sotto il cielo, in un giardino ideato e nutrito da lei con il contributo di altre donne che travalicano i confini degli schemi predefiniti.
Un altro aspetto importante di questo romanzo è la presenza femminile, che si moltiplica in personaggi secondari ma non minori, come Lady Goldbaum o la giardiniera Withers, ma sicuramente si raddensa nella figura di Greta, l’austrica nata Goldbaum e sposata a un Goldbaum inglese, che incarna la transnazionalità del cognome che porta. Greta è stata una bambina vivace e una ragazzina ribelle e anche da moglie quasi aristocratica non permette al mondo di darla per scontata: di lei questa storia ci racconta la bellezza, le trasgressioni, le sofferenze, ma è nella sua relazione con lo spazio che la circonda che ci vengono offerte le sue immagini più vivide e indimenticabili. In particolare, nei primi anni del suo critico matrimonio d’interesse, Greta è insofferente alla vita chiusa e regolata dalle decine di orologi della casa di suo marito e decide quindi di spostare se stessa, la propria anima e tutta la propria potenzialità d’azione (di donna e di personaggio) fuori, sotto il cielo, in un giardino ideato e nutrito da lei con il contributo di altre donne che travalicano i confini degli schemi predefiniti. 12 giugno 2020
Verso l'estate
2 maggio 2020
Shakespeare e l'arte di rovesciare i dittatori
 Nel corso del saggio si nominano re Lear, il sovrano impazzito che sovverte il principio per cui il monarca è deputato al controllo dell’universo, e il tiranno Macbeth, che commette l’atto empio per eccellenza dell’uccisione del re. Profondissimo suona il celebre monologo dello scozzese assassino, che una volta sul trono non può che fare i conti con i peccati che ha compiuto: “Domani, e domani e domani / striscia così, col suo misero passo, di giorno / in giorno, fino alla zeta del nostro tempo scritto; / e tutti i nostri ieri han rischiarato / ad altri pazzi / la strada della polverosa morte. / Spegniti, spegniti breve candela! / La vita non è che un’ombra vagante, un povero attore / che avanza tronfio e smania la sua ora / sul palco, e poi non se ne sa più nulla” (trad. it. di N. D’Agostino, edizione Garzanti).
Nel corso del saggio si nominano re Lear, il sovrano impazzito che sovverte il principio per cui il monarca è deputato al controllo dell’universo, e il tiranno Macbeth, che commette l’atto empio per eccellenza dell’uccisione del re. Profondissimo suona il celebre monologo dello scozzese assassino, che una volta sul trono non può che fare i conti con i peccati che ha compiuto: “Domani, e domani e domani / striscia così, col suo misero passo, di giorno / in giorno, fino alla zeta del nostro tempo scritto; / e tutti i nostri ieri han rischiarato / ad altri pazzi / la strada della polverosa morte. / Spegniti, spegniti breve candela! / La vita non è che un’ombra vagante, un povero attore / che avanza tronfio e smania la sua ora / sul palco, e poi non se ne sa più nulla” (trad. it. di N. D’Agostino, edizione Garzanti). 16 aprile 2020
Il buon soldato
 Un capolavoro che ho letto in uno di questi strani e silenziosi pomeriggi è The Good Soldier. A Tale of Passion di Ford Madox Ford, disponibile in italiano per i tipi di Bompiani.
Un capolavoro che ho letto in uno di questi strani e silenziosi pomeriggi è The Good Soldier. A Tale of Passion di Ford Madox Ford, disponibile in italiano per i tipi di Bompiani. 17 marzo 2020
Immagini e ombre, l'autobiografia di Iris Origo
 |
| Iris Origo. Fonte: BBC |
26 febbraio 2020
Libri al tempo del virus
12 febbraio 2020
Un comodino Neri Pozza
 Sul mio comodino c'è Un anno con Shakespeare di Allie Esiri, che sfoglio ogni sera appena prima di cena o prima di dormire, per leggere la citazione dedicata al giorno appena trascorso. Oggi il brano è tratto da Pene d'amor perdute (Atto IV, Scena 3), da cui estrapolo questa manciata di versi: "Dagli occhi delle donne traggo questa dottrina:/ del fuoco di Prometeo essi scintillan sempre;/ son essi i libri, le arti, le accademie/ che mostrano, contengono, nutrono il mondo intero" (trad. it. di Chiara Ujka).
Sul mio comodino c'è Un anno con Shakespeare di Allie Esiri, che sfoglio ogni sera appena prima di cena o prima di dormire, per leggere la citazione dedicata al giorno appena trascorso. Oggi il brano è tratto da Pene d'amor perdute (Atto IV, Scena 3), da cui estrapolo questa manciata di versi: "Dagli occhi delle donne traggo questa dottrina:/ del fuoco di Prometeo essi scintillan sempre;/ son essi i libri, le arti, le accademie/ che mostrano, contengono, nutrono il mondo intero" (trad. it. di Chiara Ujka). Una scrittrice che da qualche tempo sto tentando di scoprire è un'altra inglese, Daphne du Maurier, grandissima scrittrice della suspense che finora avevo conosciuto solo marginalmente, ma di cui sono davvero curiosa di sapere di più. Ho cominciato questo percorso, naturalmente, con la lettura del magnifico Rebecca nell'edizione il Saggiatore, e proprio in questi giorni sto concludendo Mia cugina Rachele (Neri Pozza), che nonostante i suoi settant'anni d'età conserva tutta la forza, la freschezza e l'asprezza di un romanzo che è molto difficile riporre. Il narratore è Philip Ashley, che racconta il suo rapporto, misterioso e ambiguo, con la cugina Rachele, moglie del defunto cugino Ambrose. La storia è potente e ombrosa fin dalle sue prime battute, con sezioni che tolgono il fiato: bellissimi scorci italiani, in equilibrio tra lo splendore dei palazzi dei ricchi fiorentini e la miseria inquietante della gente del popolo; incantevoli, vividissimi panorami della Cornovaglia, patria della scrittrice; e la rappresentazione perfetta di una passione distruttiva che lotta contro la certezza di un'impossibile armonia; una passione consapevole della propria sorte, eppure incapace di trovare tregua: "In quell'istante capii cosa Ambrose aveva visto in lei, che cosa aveva desiderato senza mai ottenerlo. Capii il tormento, il dolore, l'abisso che si apriva tra loro. Gli occhi di Rachele, così scuri, così diversi dai nostri, ci fissavano senza comprenderci. [...] Nella penombra anche il suo viso era straniero. Un viso sottile, un profilo su una moneta" (trad. it. di Marina Morpurgo).
Una scrittrice che da qualche tempo sto tentando di scoprire è un'altra inglese, Daphne du Maurier, grandissima scrittrice della suspense che finora avevo conosciuto solo marginalmente, ma di cui sono davvero curiosa di sapere di più. Ho cominciato questo percorso, naturalmente, con la lettura del magnifico Rebecca nell'edizione il Saggiatore, e proprio in questi giorni sto concludendo Mia cugina Rachele (Neri Pozza), che nonostante i suoi settant'anni d'età conserva tutta la forza, la freschezza e l'asprezza di un romanzo che è molto difficile riporre. Il narratore è Philip Ashley, che racconta il suo rapporto, misterioso e ambiguo, con la cugina Rachele, moglie del defunto cugino Ambrose. La storia è potente e ombrosa fin dalle sue prime battute, con sezioni che tolgono il fiato: bellissimi scorci italiani, in equilibrio tra lo splendore dei palazzi dei ricchi fiorentini e la miseria inquietante della gente del popolo; incantevoli, vividissimi panorami della Cornovaglia, patria della scrittrice; e la rappresentazione perfetta di una passione distruttiva che lotta contro la certezza di un'impossibile armonia; una passione consapevole della propria sorte, eppure incapace di trovare tregua: "In quell'istante capii cosa Ambrose aveva visto in lei, che cosa aveva desiderato senza mai ottenerlo. Capii il tormento, il dolore, l'abisso che si apriva tra loro. Gli occhi di Rachele, così scuri, così diversi dai nostri, ci fissavano senza comprenderci. [...] Nella penombra anche il suo viso era straniero. Un viso sottile, un profilo su una moneta" (trad. it. di Marina Morpurgo).Quando avrò terminato Rachele, dovrò scegliere se cominciare Daphne di Tatiana De Rosnay (la biografia della scrittrice che Neri Pozza ha pubblicato nel 2016: titolo originale, Manderley For Ever) o deviare dal cammino e intraprendere il magnifico viaggio dentro la nuovissima edizione di Via col vento di Margaret Mitchell (Neri Pozza 2020) oppure ancora entrare nello scintillante mondo de I Goldbaum di Natasha Solomons (Neri Pozza 2019), o forse distrarmi un po' con il nuovo capitolo dei Mitford Murders di Jessica Fellowes (Neri Pozza 2020)...
14 gennaio 2020
Piccole donne, il film
5 gennaio 2020
Louisa e le piccole donne
 |
| Foto dello scrittoio di Louisa May Alcott, di Annie Leibovitz, tratta dal suo libro Pilgrimage |