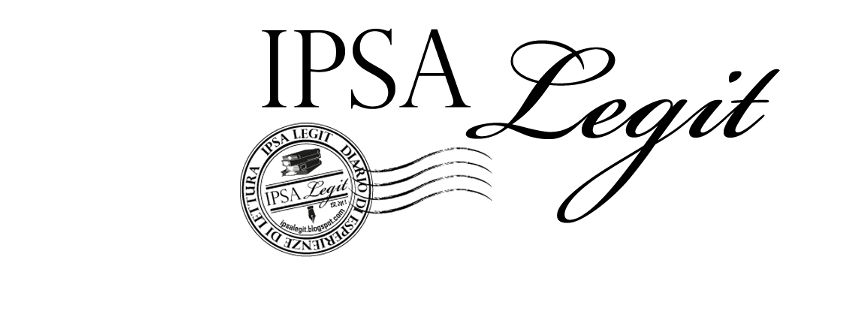Il racconto breve è forse la più difficile tra le forme della narrativa. In un numero limitato di righe l’autore deve presentare la situazione e i personaggi, innescare il motivo del turbamento dello status di partenza, attivare l’evoluzione della vicenda (generalmente con l’inserimento di nuovi personaggi) e arrivare infine a una sintesi e a una conclusione. Elizabeth Gaskell è stata un’autrice che nel romanzo ha espresso il massimo delle sue doti, ma è stata anche devota alle short stories, producendone più di cinquanta nel corso della sua carriera. Uno di questi racconti, “The Manchester Marriage”, fu scritto per essere incluso nella raccolta, decisa da Charles Dickens, A House to Let, pubblicata nel numero di Natale 1858 del periodico da lui diretto Household Words. L’opera, i cui autori sono Dickens, Gaskell, Wilkie Collins e Adelaide Anne Procter, è stata tradotta interamente grazie alla casa editrice Jo March, che nel 2013 ha offerto al pubblico italiano La casa sfitta (trad. di C. Caporicci, V. Mastroianni e L. Ricci).
“Il matrimonio di Manchester” è una storia sviluppata su piani temporali intercalati, che fonde tra loro atmosfere completamente opposte, facendoci assaggiare – come solo, secondo me, Gaskell e Dickens, hanno saputo fare – ironia e spirito tragico nello stesso boccone. È un racconto che si può definire fortemente gaskelliano, sia, appunto, per il suo tono attraente, rassicurante e inquietante allo stesso tempo, sia per i suoi particolari narrativi, che inducono a ritenerlo una sorta di prova di costruzione di quella che sarà la trama di Gli innamorati di Sylvia. Il tema dominante è infatti quello della scomparsa di un uomo (argomento quasi ossessivo per Gaskell – il cui fratello fu dato per disperso in mare – che scrisse non a caso una raccolta di storie intitolata Disappearances), ma anche alcuni dettagli tradiscono una grande somiglianza con il romanzo: la menzione di un dialetto del Nord, il carattere chiuso e poco espansivo della protagonista femminile, il matrimonio contratto da parte di lei per ragioni di sicurezza economica, la paura di una maledizione lanciata sulla famiglia e infine il passo «Ora che [il marito] se ne era andato per sempre, Alice provò all’inizio uno struggente, anelante amore per il cugino gentile, l’affezionato protettore che non avrebbe potuto vedere mai più – un intenso desiderio di mostrargli la sua bambina», che ci ricorda inequivocabilmente le ultime battute di Gli innamorati di Sylvia.
La figura di Norah, poi, è l’ennesimo esempio della schiera di domestici affezionatissimi che Gaskell seppe creare con maestria narrativa e lucidità psicologica. Nella devozione totale dimostrata nei confronti della sua padrona, Norah ci ricorda la Dixon di Nord e Sud, la Betty di Mogli e figlie, la sua straordinaria omonima in Mia cugina Phillis e soprattutto il Kester di Gli innamorati di Sylvia: personaggi verso i quali il lettore non può che sentirsi attratto, per un senso di tenerezza e di ammirazione per la loro lealtà. Forse per qualche sfumatura del loro carattere la scrittrice si ispirò alla «nostra cara Hearn», la fedele governante che prestò servizio nella famiglia Gaskell per più di cinquant’anni.